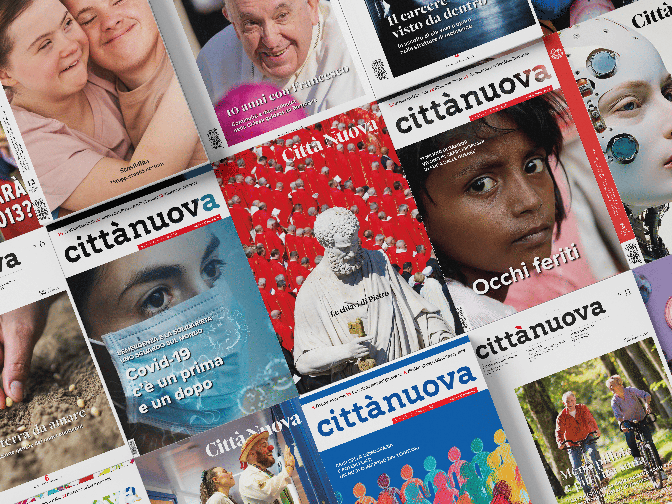A girarci assieme per le vie del centro storico, si passa di sorpresa in sorpresa: è una Roma imprevista, inedita, quella che Carlo Pavia – giovane scrittore, documentarista e archeologo – fa rivivere, non senza però il soccorso di una dote: credere in ciò che non si vede. Sì, perché la "sua" è una Roma sotterranea, segreta, accessibile solo a pochissimi eletti.
Qualche esempio. Siamo a piazza della Cancelleria, davanti all’enorme palazzo rinascimentale fatto costruire dal cardinal Riario. Tutto qui? Nossignore. «Qui sotto – spiega il nostro –, insieme a un laghetto profondo dai tre ai sei metri, ci sono un tratto dell’euripus (canale) di Agrippa, il sepolcro di Aulo Irzio e i resti della primitiva basilica di San Lorenzo in Damaso. «Non molto lontano da qui, verso piazza Campo de’ Fiori, ho scoperto di recente due colonne che da una cantina proseguono fino al secondo piano di un palazzo; mentre a via Amba Aradam mi è bastato calarmi in un tombino nel bel mezzo del traffico per ritrovarmi in un ninfeo semisommerso, con splendide pitture della prima età imperiale».
Un mitreo o un criptoportico qui, una cisterna o un peristilio là… e pian piano – tra cavi, condotte e un vero labirinto dì cunicoli – ecco snodarsi la stupefacente mappa di un’altra Roma sconosciuta ai più, di cui Pavia si sente in certo modo "sindaco": un mondo silente e che induce al raccoglimento quanto caotico e dispersivo è quello in superficie. Lo diresti un Ambrogio Fogar che, invece di scorrazzare per i lembi più remoti e incontaminati del pianeta, ha scelto un altro tipo di esplorazione, che se a qualcuno potrà fare arricciare il naso, per lui ha un fascino indescrivibile: «tant’è – commenta argutamente – che se ogni tanto non mi tuffo nelle oscurità catacombali del sottosuolo e posso respirare gli umidi sentori che ne promanano, divento inquieto, nervoso. Che vuoi? Sono un po’ “sotterraneo-dipendente”».
Se gli occorrono coraggio e un pizzico d’incoscienza nei suoi viaggi "all’ingiù", dove talvolta si fa accompagnare da qualche amico o studioso (come quella professoressa di botanica che impazzì di gioia scoprendo nei sotterranei del Colosseo un tipo di flora del tutto particolare: pare discenda addirittura da quella introdotta attraverso i pollini impigliati nelle pellicce delle fiere d’un tempo), dimostra tenacia e pazienza allorché, per accedere ad infera, si sottopone alle snervanti trafile burocratiche relative alla richiesta di permessi (le varie competenze si distribuiscono tra comune, sovrintendenza e Vaticano; nei casi limite gli è occorso chiederne tre di permessi, per visitare un solo ambiente!).
Per quanto riguarda invece i privati, Pavia sfodera un’altra sua qualità, che è quella della simpatia, della immediatezza nel rapporto, per cui non gli è difficile trovare tra la gente semplice del popolo dei "complici" che gli schiudono cantine e segreti recessi delle loro abitazioni per le sue incursioni nel sottosuolo: «Dottò, venga a dare un’occhiata a ‘sto rudere…». Lui va, osserva, commenta: a volte si tratta di reperti già noti agli studiosi, ma poi dimenticati; a volte invece salta fuori l’inedito.
Carlo Pavia è ormai un nome nel campo della Roma sotterranea, grazie ai volumi pubblicati sull’argomento e splendidamente illustrati da sue foto. Ma oltre che dalla ricerca di un risultato scientifico, la sua attività – rischiosa per certi versi ma anche ricca di soddisfazioni – trae incentivo dalla sfida a tentare certi traguardi che altri non hanno osato, a verificare le proprie possibilità; senza escludere la tensione a quel "qualcosa di più" tipica dell’uomo, che si configura come un’avventura anche nel senso più propriamente spirituale.
Me lo conferma lo stesso Pavia, a proposito delle sue esplorazioni nelle catacombe romane: «Quante volte, da solo in quelle gallerie oscure, nel silenzio più assoluto, attendendo al paziente lavoro di documentazione fotografica, mi stupivo per le fatiche e le difficoltà affrontate da quei nostri lontani predecessori nel preparare un luogo che accogliesse i corpi dei credenti in attesa della resurrezione; e davanti agli affreschi che decorano cubicoli e arcosoli, testimonianze di una fede semplice e genuina, di un amore che vince la morte, ho sperimentato un vivo senso di comunione con i credenti di allora, tanto da risalire alla superficie diverso da come ero disceso, con l’anima rifatta».