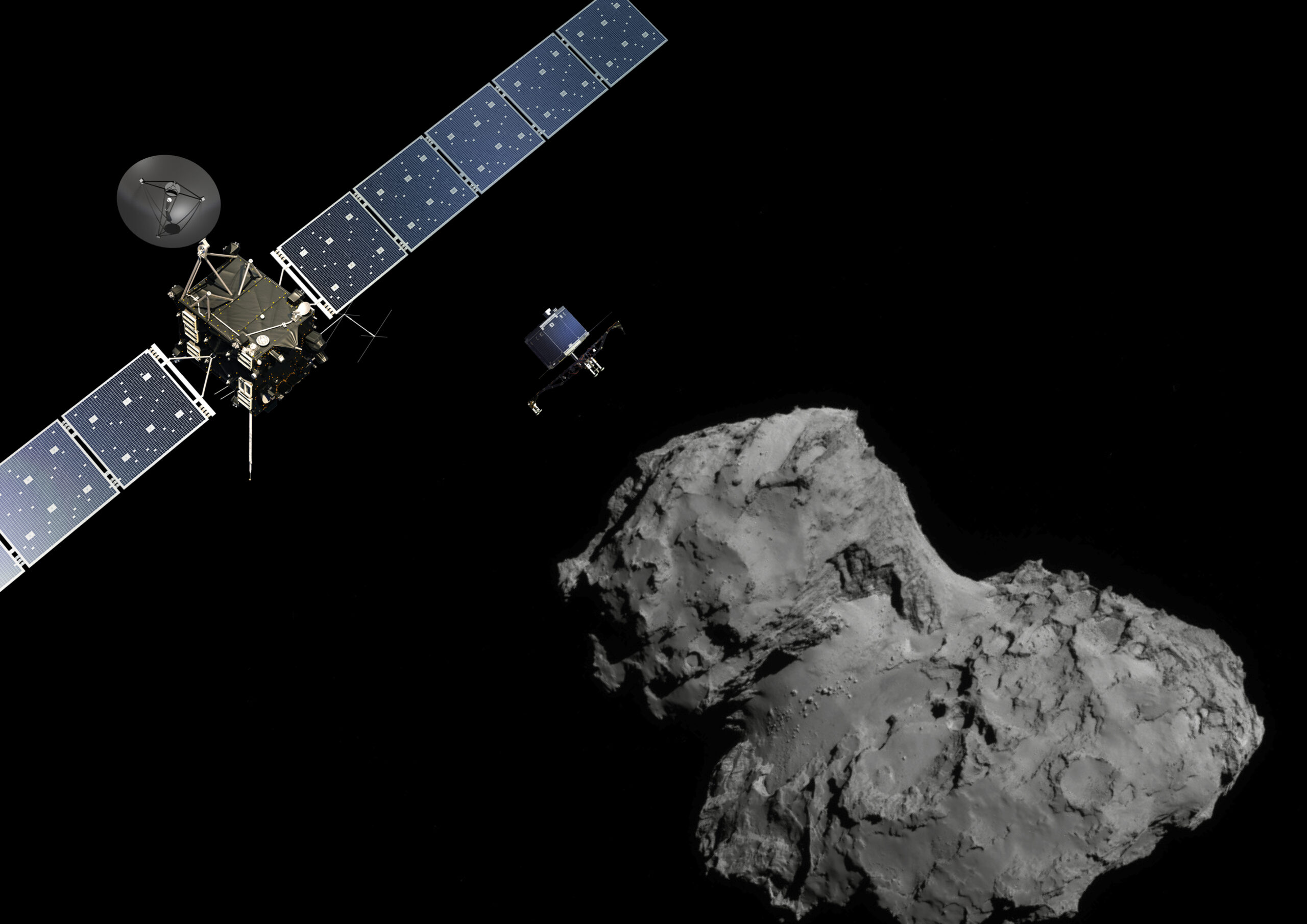Da quando ero nato, mamma si era dimessa dalle Materie Plastiche per dedicarsi alla famiglia. La sera, in quel piccolo alloggio di via Capelli, c’era il rito della lastra di zinco. Dopo cena e aver riordinato, papà poggiava sul tavolo da cucina, l’unico posto in cui si poteva lavorare, studiare, giocare, insomma l’unico posto, la celebre lastra di zinco. Su di essa disponeva rotoli di plastica che, usando modelli di carta, ritagliava con un coltello affilato per farne sagome. Mentre lui tagliava si ascoltava la radio, o mi raccontava qualcosa.
Un giorno mi spiegò del muro invisibile creato secoli prima da un certo Mesmer. Mi disse anche dei fenomeni che accadevano con un certo Rol, che viveva a Torino e spesso andava a messa alla Consolata. Papà era sempre attratto da ciò che si spingeva verso il soprannaturale e oltre. Mamma ascoltava senza dire una parola, era evidente che a quegli argomenti non dava alcun valore. Ma io ne ero entusiasta. Il giorno dopo mamma cuciva alla macchina a pedali Singer i ritagli preparati da papà, che diventavano borse di plastica. Era tanto lavoro per pochi soldi, ma serviva ad arrotondare il magro stipendio di papà.
C’erano tante persone che passavano nel nostro alloggetto, che in realtà io ritenevo una reggia. C’erano Malvina e Pippo e i loro due figli, Gina e Carlo, con cui giocavamo. Avevano un’altra sorella, Laura, che si era innamorata di Donald, un soldato americano venuto con l’esercito alleato per la liberazione dell’Italia. Si erano sposati e lei era andata a vivere in America, nel Massachusetts. Siccome Pippo e Malvina non se la passavano troppo bene in Italia – Pippo era sarto ma gli affari buttavano male –, li invitò a raggiungerli in America. Partirono. Ma Malvina non si adattò a vivere in quella terra. Dopo pochi anni morì di malinconia.
Laura ogni tanto veniva in Italia a trovare la sua mamma, chiamata “mammina Bursa”. Per Italia ‘61 mi portò al Luna Park allestito al Lingotto a Torino. Una meraviglia, un sogno. Viaggiammo sulla monorotaia. Rivedrò poi Gina e Carlo anni più tardi, quando sarei andato ad abitare a New York. Prendevo l’autobus dalla Penn Station e raggiungevo Hartford dove vivevano. Carlo mi portava con lui in discoteca, fino alle ore beate. «In focolare fate una vita triste, ti faccio divertire un po’ io», mi diceva. Poi aggiungeva, «mia zia (Desi-Dirce) non fa una vita triste in focolare, ma lei è una capa, tu non mi sembri messo un granché bene». Lui la vedeva così.
Fra gli ospiti assidui di via Capelli c’era Luciano, che era fidanzato, ma non era certo se sposarsi o no. Ne parlava a lungo con i miei. Io non capivo tanto di quei discorsi, era come una musica che mi accarezzava le orecchie. C’era anche Renato, che viveva una situazione analoga. Anche lui veniva e parlava. Poi Luciano sciolse il fidanzamento e diventò focolarino. Anche Renato sciolse il fidanzamento, e diventò prete. Avevano trovato la loro vocazione.
C’era Guido, un passato da sindacalista. Lui veniva la domenica mattina prima delle sei a prendere in Lambretta mia mamma per andare a vendere di fronte alle chiese la rivista Città Nuova, che era nata da poco, nel ‘56. Si cominciava dalla messa prima, quella delle sei, che allora c’era ancora. Mio padre rimaneva a casa con noi. Ma il più delle volte ci andava lui, con la sua Lambretta. Tutte le domeniche mattina così, uno dei miei era a vendere Città Nuova.
Guido mi confessò poi: «Eravamo proprio incoscienti allora, vivevamo in un tale clima soprannaturale, che mai mi venne in mente che il tuo povero papà forse provava un po’ di gelosia a vedere tua mamma che saliva sulla mia Lambretta; erano appena sposati, ma eravamo così allora». C’era anche Egidio che frequentava casa nostra. Era medico e divenne il nostro consulente famigliare. Diceva ai miei: «Questi bambini sono pallidi, hanno bisogno di nutrimento, di aria aperta». Per il nutrimento la spinse a darci da mangiare le “cervella”. Era un cibo economico, ricco di proteine e vitamine B. Quante disgustose cervella ho dovuto mandare giù grazie a lui.
Per l’aria aperta, a primavera, ci portava fuori Torino dove lui lavorava presso l’Istituto Lombroso. Era un complesso psichiatrico che ospitava persone, soprattutto giovani e giovanissimi, considerate difficili, pericolose o ribelli. Ci raccontava un sacco di storie su di loro. Con lui lavorava don Silvano, un altro dei frequentatori di casa nostra. Mentre loro erano al lavoro, Egidio lasciava mia mamma e noi bambini nei prati. Stavamo al sole, all’aria aperta. C’erano tanti alberi di ciliegie, e noi ne raccoglievamo a più non posso. Ho sempre associato il nome di Lombroso alle ciliegie.
Fra quelli che frequentavano casa nostra c’era don Enrico, giovane viceparroco della nostra parrocchia. Alla sera ogni tanto veniva e parlava con i miei. Quando eravamo piccoli, su richiesta di mio papà, portava con sé una bottiglietta con l’acqua santa, per benedire me e mia sorella, perché non piangessimo tanto di notte, e li lasciassimo riposare un po’, che al mattino dovevano alzarsi presto per lavorare.
C’era poi Irma, e anche Marco che ci facevano da babysitter. Marco mi fece entusiasmare al gioco del Meccano. Un giorno mio papà aveva dato la tinta in cucina, un bel verde chiaro. Finito il lavoro e risistemato tutto, i miei uscirono per fare la spesa. Io presi un cacciavite e con la punta incisi sul muro la sagoma di una barchetta con la vela. Quando tornarono, mio padre andò su tutte le furie. Chi è stato? Io negai e negai. Mai dissi la verità. Mia sorella anche, ma a ragione. Ora che sei del cielo lo posso ammettere, papà, sono stato io.
Una domenica pomeriggio i genitori erano andati a riposare in camera da letto. Io e mia sorella giocavamo, fingendo di essere al mare. Ci tuffavamo da una sedia su una bacinella di plastica azzurra. Capitò che dallo slancio la bacinella scivolò sul pavimento e ruppe un vetro della porta che dalla cucina dava sul balcone. I miei si alzarono immediatamente al rumore dello schianto. Papà cominciò a sgridarci. Ma adesso chi paga il vetro? Vi rendete conto di quanto dobbiamo lavorare e tener conto di ogni dieci lire? E voi combinate guai con i vostri stupidi giochi? Andate forse voi a lavorare? Mia sorella uscì dalla cucina, aprì la porta, disse: «Vado a lavorare». Scese la scale e si mise a camminare sul marciapiede. Aveva quattro anni. Papà ci rimase di stucco, le corse dietro e la riportò a casa. Io mi dimostrai più codardo, avevo fatto il callo alle sgridate. Pensai: meglio star qui a farmi sgridare, che tanto poi passa, che uscire al freddo.
Tempo prima, nel ‘56, c’erano stati i fatti di Ungheria, quando i sovietici avevano duramente represso un tentativo di instaurare un regime un po’ più libero in quel Paese. La cosa turbò alcuni intellettuali del PCI, come Italo Calvino che lasciò il partito, ma la maggior parte dei comunisti italiani non fu affatto turbata e tenendo basso profilo si schierò con i sovietici. Chiara Lubich colse nella rivolta ungherese, a cui tanti volontari fra la gente comune avevano partecipato, lo spunto per creare un nuovo gruppo del focolare, i “volontari di Dio”. Mio papà ne fu coinvolto.
Un giorno mi portò con lui a fare pulizia in un alloggetto che avevano affittato come sede dei “volontari”. Strabuzzai gli occhi. In uno scaffale c’era quello che era il mio desiderio segreto da tanto tempo: un pallone di cuoio. Quando lo presi in mano mi accorsi che era anomalo. Non era tondo, ma ovale. Era una pallone da rugby, ma chi sapeva allora che cosa era il rugby? Lo portai a vedere a miei amici, per giocarci. Mi presero in giro: «Come si fa a giocare con un pallone così?». Lo portai a casa e lo nascosi. Da bambino associavo i volontari a una palla con cui non si riesce a giocare.
Quando i miei dovettero assentarsi per alcuni giorni per un incontro, fui ospitato nel focolare che si era trasferito in via Filadelfia. Si prendeva cura di me un certo Nino, che mi portava in giro in auto per il suo lavoro: faceva il rappresentante di Città Nuova. Fu lui a farmi conoscere la squisitezza di una fetta di pane cosparsa di olio di oliva. Di cognome lui si chiamava Oliva, e io lo assocerò sempre a quel cibo delizioso a cui mi aveva introdotto.
Fra quelli che frequentavano casa nostra in via Capelli c’era Andrea. Lui si sedeva sulla nostra unica poltrona e faceva i versi degli animali. Mi faceva morire dal ridere. Una mattina di luglio del ‘60 ci fu una telefonata. Mamma, posata la cornetta, disse, accendiamo la radio. Giornale radio regionale. La notizia: un giovane su una Lambretta è stato travolto da un camion. Un incidente gravissimo. Era Andrea. Poco dopo morì.
Ma dunque i focolarini muoiono? Sembrava risuonasse la stessa domanda di due millenni prima fatta dai Tessalonicesi a Paolo: ma dunque i cristiani muoiono? Si pensava di essere alla fine dei tempi, che all’arrivo del Paradiso in terra ci mancasse poco. Chiara Lubich aveva lanciato lo slogan: un’anima al giorno! Se ognuno del focolare avesse conquistato a Dio una persona ogni giorno, e se queste avessero fatto altrettanto, nel giro di pochissimo tempo il mondo sarebbe stato invaso dall’unità. Erano idee, viste con gli occhi di oggi, forse un po’ ingenue, ma davano alla vita una dimensione di intensità e di entusiasmo contagioso, la rendevano grandiosa.