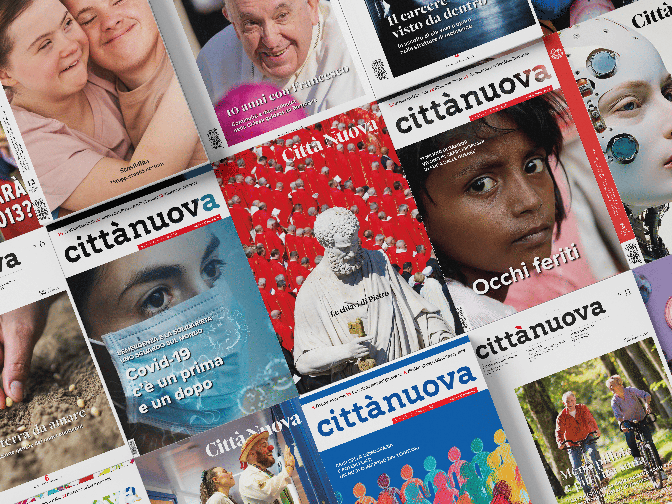Il referendum indetto dalla Cgil, il cui voto è previsto per l’8 e il 9 giugno prossimi, non coglie nel segno. Vediamo le ragioni.
Il primo quesito dei quattro in materia di lavoro, sui cinque formulati, si propone di ripristinare come tutela ordinaria la reintegra in favore di tutti i lavoratori illegittimamente licenziati nelle imprese con più di 15 dipendenti. L’obiettivo è il ritorno all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970), nella versione modificata dalla c.d. legge Fornero (legge n. 92 del 2012), e quindi il superamento del c.d. Jobs Act (d.lgs. n. 23 del 2015), applicabile a tutti i lavoratori assunti dal marzo 2015, che ad ordinaria aveva invece eletto la tutela risarcitoria.
Comprendiamo e rispettiamo la portata ideologica di cui è stato ed è ancora pregno il famigerato articolo 18, ma a sfuggire è un dato essenziale: più che licenziare, oggi, le imprese provano a tutti i costi ad attrarre e mantenere in organico quei lavoratori che, però, o non nascono o non si trovano.
La natalità ha toccato il minimo storico di 390mila nascite nel 2025 con il conseguente possibile venir meno di 5 milioni di lavoratori da qui a vent’anni, non riescono ad occuparsi 200 mila posti di lavoro e 10 milioni di over50 sono in attesa di reskilling nelle aziende.
Il licenziamento, in altri termini, è diventato un’extrema ratio e quando avviene in violazione di legge, i lavoratori, piuttosto che tornare da chi li ha voluti fuori, preferiscono incassare un buon risarcimento e cedere alle lusinghe di chi ne è alla disperata ricerca ed è pronto ad assumerli.
Il secondo quesito persegue lo scopo di superare il tetto massimo di 6 mensilità di risarcimento previsto dalla legge n. 604 del 1966 in favore dei lavoratori illegittimamente licenziati nelle imprese con meno di 15 dipendenti. Se vincesse il “si”, il Giudice potrebbe condannare il datore di lavoro a importi molto alti, commisurati all’effettivo danno subito.
Ciò che sfugge, in questa ipotesi, sono due dati che l’esperienza vissuta suggerisce.
Il primo è che le imprese di dimensioni ridotte non hanno le potenzialità economiche di quelle medie o grandi, sono spesso padronali, sbarcano il lunario mese per mese e la condanna ad un risarcimento elevato rischia di annientarle. La loro dimensione “familiare” ha anche convinto il legislatore, dopo l’approvazione dello Statuto dei lavoratori, a esonerarle, fatti salvi alcuni casi, dalla sanzione della reintegra, che sarebbe suonata come il ripristino di una “relazione sentimentale” infranta.
Il secondo è che è più facile sottrarsi al pagamento se i conti in banca non sono gonfi e agli assetti societari non sono intestate ne’ proprietà immobiliari nè quelle degli strumenti di lavoro. E’ vero che queste considerazioni potrebbe valere meno per le “micro” imprese operanti nel campo dell’innovazione e della tecnologia in grado di raggiungere alti fatturati anche con una manciata di dipendenti ma occorre verificare quale percentuale esse effettivamente cubano rispetto a quella miriade di tradizionali piccole imprese disseminate sul Paese, che ne costituiscono l’ossatura produttiva”.
Il terzo quesito mira, con il dichiarato scopo di combattere la precarietà, a ripristinare l’obbligo della causale per i contratti a termine fino a 12 mesi che, per effetto dell’articolo 19 di un altro pezzo del c.d. Jobs Act (d.lgs. n. 81 del 2015), oggi sono invece stipulabili senza l’indicazione di una specifica ragione. Tra esse, rientrano quelle di natura tecnico organizzativa e produttiva, individuate dai contratti collettivi o, fine alla fine del 2025, in sede individuale.
Ma un cerotto non può certo suturare una ferita profonda. E ingaggiare un lavoratore a tempo determinato senza una motivazione specifica per il massimo di un anno non equivale al precariato ma ad un periodo di prova più lungo rispetto ai 6 mesi già previsti dalla legge. Al termine di esso, egli infatti o è stabilizzato, o è assunto per ulteriori 12 mesi a fronte di una causale specifica oppure semplicemente smette di lavorare per quel datore di lavoro.
A trasformare da buona a cattiva la flessibilità sono invece disinvolte successioni di contratti a termine, rinnovi e proroghe fittizie, somministrazioni a termine dopo contratti a termine. Ma la legge già persegue questi abusi.
Potrebbe invece aver senso l’idea di rimettere soltanto alla contrattazione collettiva, anziché anche a quella individuale, l’indicazione delle ragioni che possono giustificare l’apposizione di un termine al contratto di lavoro ma, a dispetto dell’intento dei promotori referendari, a condizione del mantenimento del regime di “acausalità’” per i primi dodici mesi. Questo infatti potrebbe generare maggior chiarezza interpretativa e quindi una riduzione del contenzioso ma, per converso, priverebbe le parti del rapporto di lavoro della tradizionale autonomia negoziale individuale. Inoltre, l’esercizio di questa autonomia e’ gia’ oggi, come visto, possibile solo in funzione suppletiva dei contratti collettivi di lavoro e, salvo (auspicabili) proroghe, soltanto fino al 31 dicembre 2025.
L’ultimo quesito vuole, infine, estendere al committente la responsabilità per i rischi specifici degli appaltatori e dei subappaltatori. Ad oggi, il primo risponde soltanto in alcuni casi in solido con i secondi. Ad esempio, per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi, per il mancato versamento delle ritenute fiscali o, al ricorrere di determinate condizioni, per i rischi c.d. interferenziali.
Se vincesse il “si”, il committente risponderebbe nell’appalto anche per i rischi legati ad attività che non gestisce come quelli per incidenti e infortuni, per esposizione a sostanze chimiche, rumori o vibrazione o infine per stress da lavoro correlato. I rischi, in altri termini, che confluiscono nel c.d. Documento di valutazione dei rischi (Dvr) dell’appaltatore e del subappaltatore.
Ed invece, a dover essere combattute sono tutte quelle interposizioni di manodopera mascherate, che vedono protagoniste cooperative od imprese che violano anche solo gli standard minimi di sicurezza sul lavoro.
Non solo. I cambiamenti del mondo del lavoro non decollano né sulle ali di una legge ne’ su quelle di un referendum.
Innovazione tecnologica, riduzione dei costi dell’energia, incentivi alla logistica, contenimento dei tassi di interesse reale, credito di imposta, Ires premiale sono solo alcune delle politiche più urgenti che il governatore della Banca di Italia, nella sua relazione del 30 maggio scorso, ha suggerito per la ripresa del sistema produttivo.
In definitiva, il referendum, oltre che fallire il bersaglio, ci interroga su un rischio. Quello che chi lo ha indetto finisca come il cuoco di bordo dell’aneddoto di Kierkegaard il quale, durante la tempesta, dal megafono del comandante, annuncia ai marinai ciò che mangeranno invece della rotta.
VEDI TUTTI GLI INTERVENTI SUL FOCUS DI CITTA’ NUOVA