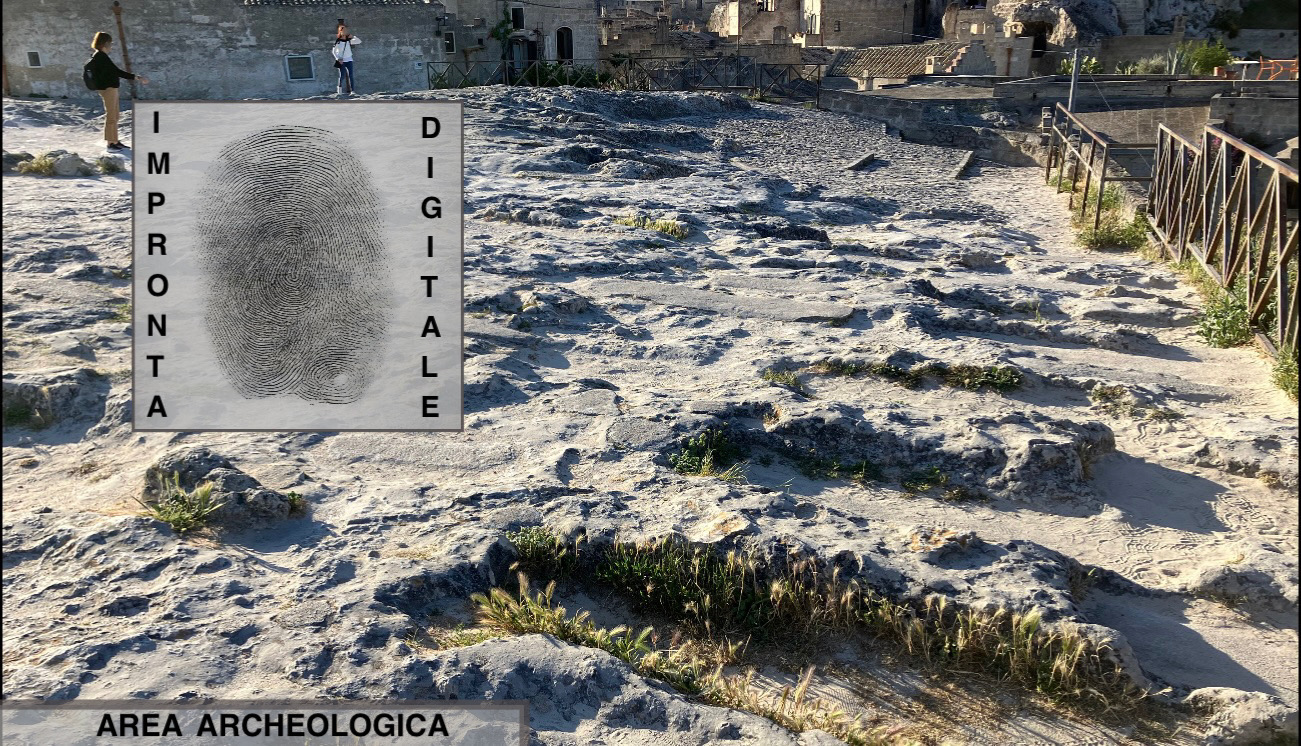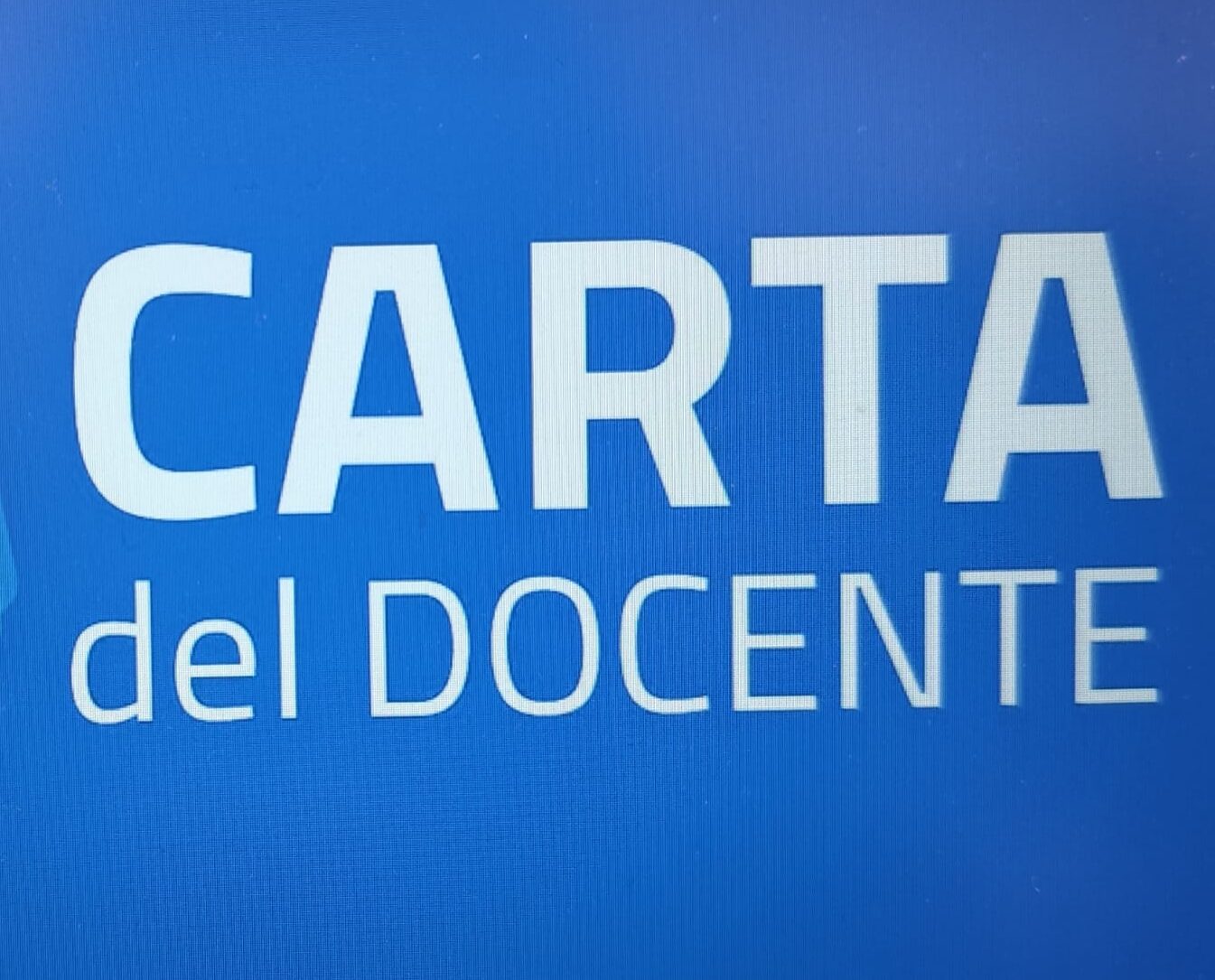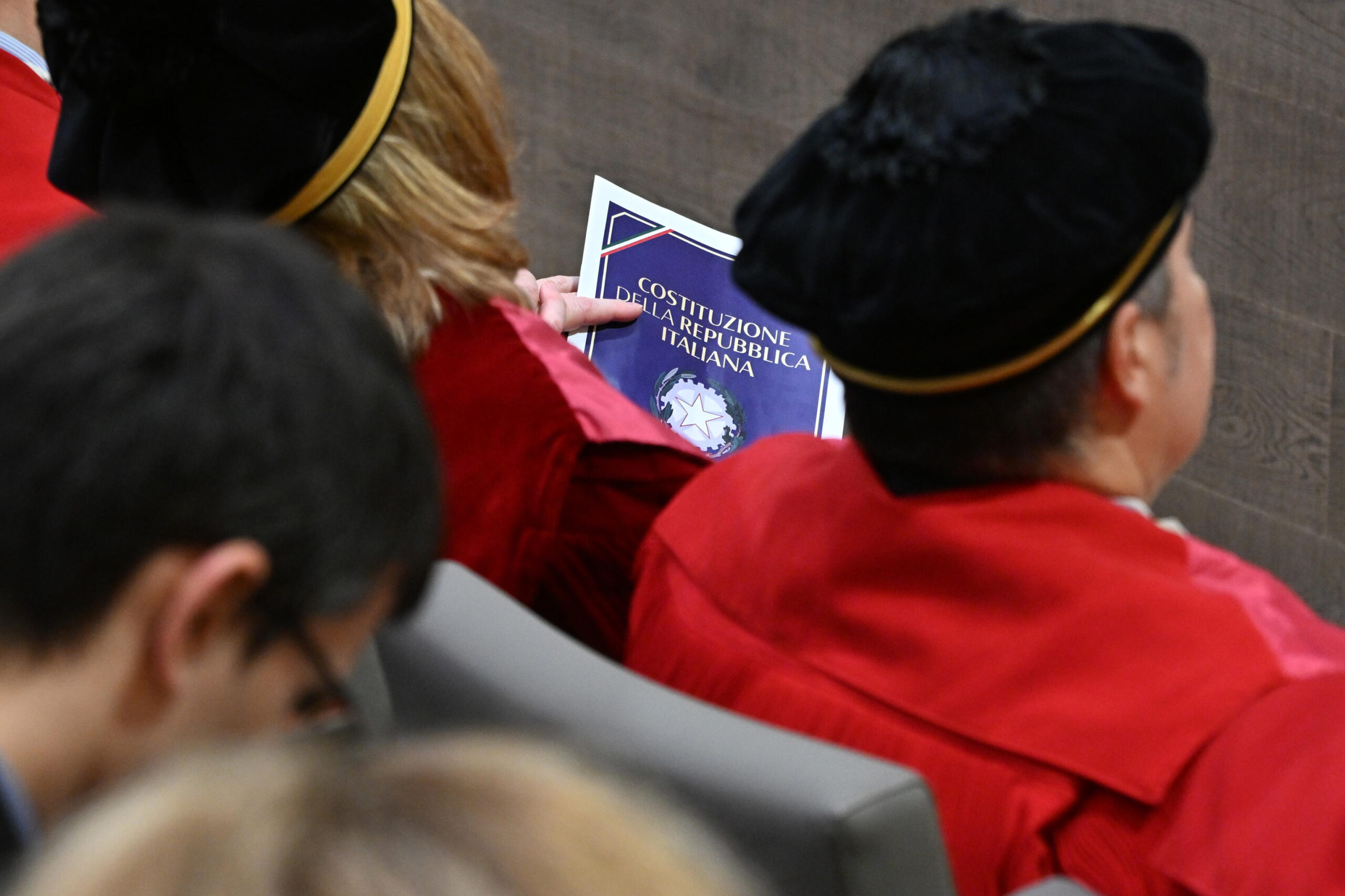La tecnologia che domina la nostra era è detta digitale, da digit parola inglese che indica la conversione in numeri dei sistemi operativi di ultima generazione. Digitus però in latino significa dito e infatti i primi rudimentali computi numerici che hanno portato agli attuali super computer, l’umanità li faceva usando proprio le dita.
Abbiamo così rintracciato le impronte arcaiche lasciate da quelle dita, non più però per fare calcoli, bensì per esplorare un’estensione dell’archeologia che è sì digitale, ma non nel senso convenzionale e comunemente conosciuto del termine.
L’archeologia digitale
Ci addentriamo in un mondo fatto di tracce e segni invisibili a occhio nudo e frutto dell’uso che l’uomo magno-greco del V sec. a.C. ha fatto delle proprie dita per plasmare dall’argilla eleganti vasi, anfore e crateri. Reperti archeologici questi, su cui c’era l’impronta immateriale dell’arte di chi li realizzò, ma, non poteva darsi che gli artefici vi avessero lasciate anche le loro impronte materiali?
Ispirati da questa intuizione, nel 1996, alcuni brillanti archeologi della Basilicata, per la prima volta nella storia archeologica d’Italia se non d’Europa, pensarono di andare a scovare quelle impronte: era nata l’archeologia digitale. .
Sulle tracce dei dermatoglifi
Sulla cute delle nostre mani sono presenti i dermatoglifi, microscopiche creste e solchi circolari il cui sebo oleoso fa sì che essi restino impressi su ciò che tocchiamo, generando appunto le impronte digitali. Nel nostro caso, però si trattava di impronte lasciate migliaia di anni prima e dunque trovarle sembrava un’impresa impossibile.
Gli archeologi lucani però non si persero d’animo e chiesero aiuto a dei veri e propri detective.
Dattiloscopia: dal crimine all’archeologia
Quando la contattarono dal museo archeologico di Metaponto (Basilicata), la Polizia di Stato pensò che si trattasse dei soliti tombaroli, perché fino a quel momento, la dattiloscopia, vale a dire l’individuazione e il prelievo delle impronte digitali, era una pratica investigativa circoscritta al settore della criminologia e non aveva niente a che fare con l’archeologia.
Le analisi della scientifica provarono che «i vasi del V sec. a. C. rinvenuti nel fossato di scarico del quartiere kerameikos (dei ceramisti) dello scavo archeologico di Metaponto, non erano stati realizzati dalla stessa mano, bensì da quattro diversi artigiani che operavano nell’officina dove veniva prodotto il vasellame».
L’Identikit Metaponto
All’indomani di quella clamorosa scoperta sull’identikit dei ceramisti di Metaponto, l’importanza della dattiloscopia applicata all’archeologia, mi venne spiegata dal suo ispiratore, il professore Dinu Adamesteanu, allora 83enne e dedito ai suoi studi privati, dopo un’intera vita dedicata all’archeologia della Basilicata e del Meridione.
« Le evidenze della polizia scientifica – mi disse Adamesteanu – confermano la presenza di una sinergia lavorativa in quel laboratorio del kerameikos di 2.500 anni fa. La prima fase di tornitura del vaso era ad opera del maestro ceramista che vi imprimeva così le sue impronte digitali insieme a quelle dell’apprendista di bottega che subito dopo di lui maneggiava il vaso per levigarlo. Il ceramografo, da ultimo immergeva il vaso nella vernice e tenendolo per l’orlo o per il piede (bordo inferiore) vi lasciava anch’egli i segni dei polpastrelli».
La perfetta imperfezione
Le ricerche svolte dall’ archeologia digitale dimostrarono dunque che nell’atelier metapontino della ceramica, già nel V sec. a.C. esisteva una concezione moderna di “linea di produzione” finalizzata a razionalizzare il lavoro artigianale, a impiegare la manodopera specializzata nelle varie fasi di creazione di un vaso, e a garantire un livello artistico-qualitativo dei manufatti molto elevato.
Non a caso noi figli della super tecnologia consideriamo quei meravigliosi vasi dei capolavori di perfezione, laddove i maestri ceramisti che li avevano realizzati 2.500 anni fa, li ritennero imperfetti, mal riusciti e dunque li gettarono nelle fosse di scarico.
Impronte perdute
L’entusiasmo scaturito dagli straordinari risultati dell’archeologia digitale, spinse negli anni ’90 l’allora ministero per i Beni Culturali e Ambientali a progettare database e banche dati per catalogare e classificare le impronte digitali archeologiche, le officine di ceramiche, le tecniche usate e la rotazione delle maestranze nella produzione artistica.
Niente di tutto questo però è mai stato realizzato, sebbene ogni qualvolta si ricorra alla dattiloscopia archeologica, arrivino puntuali delle eccezionali scoperte. Pensiamo alle mini-impronte digitali trovate sulle ceramiche siriane di 4.500 anni fa, che testimoniano un notevole impiego di bambini nella lavorazione artigianale; oppure pensiamo alle impronte trovate sulle figurine in argilla egizie del III millennio a.C., che hanno fatto riaffiorare un’intera classe artigianale incredibilmente operosa e tuttavia ignorata dalle pagine della storia egizia.
L’adeguato sviluppo dell’archeologia digitale, in questi ultimi trent’anni, forse ci avrebbe fatto apprendere prima e meglio i pregi e i difetti del lavoro artigianale dei millenni trascorsi, portando con largo anticipo alla miglioria delle attuali politiche del lavoro manuale e minorile.
Così come perseverando nello studio dell’impiego delle maestranze nelle officine del V sec. a.C., magari saremmo approdati anzitempo a norme più adeguate sulla formazione, apprendistato e specialistica dei giovani.
E forse, continuando a ricercare e comprendere le impronte millenarie lasciate dalle classi sociali più sofferenti del Medio Oriente, invece di abbandonarle al proprio destino, forse oggi non assisteremmo alle tragiche escalation belliche in quei territori.
Ma chi può dire tutto questo? Di certo però le orme di quegli archeologi lucani restarono impresse sui lidi di Metaponto, su quelle spiagge sacre sì agli dei, ma fatte pur sempre di labile sabbia.