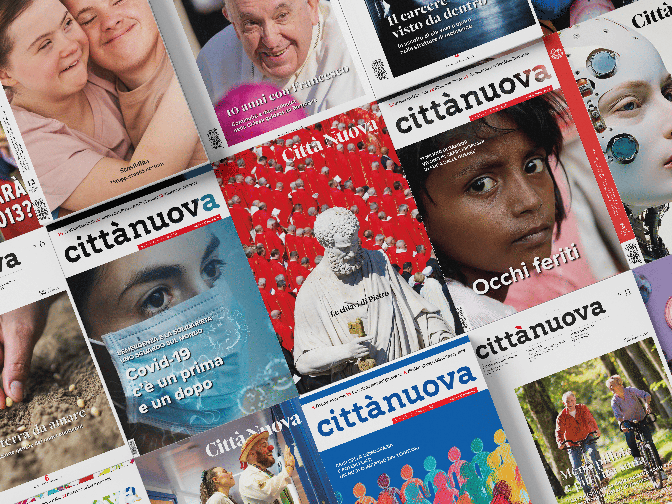Il nostro cervello nel corso della vita registra memorie molto diverse tra loro, che tendono a consolidarsi a livelli differenti in base alla loro rilevanza.
Le informazioni vengono consolidate all’interno dell’ippocampo, in cui migliaia di sinapsi promuovono la trasmissione dei dati appresi da neurone a neurone, grazie ai neurotrasmettitori. In questo modo il meccanismo di comunicazione continua tra i neuroni ed attraverso esso è possibile il recupero dei ricordi.
Il consolidamento della memoria è un processo dinamico, generativo, trasformativo e persistente che si propone di bilanciare il mantenimento di rappresentazioni interne del mondo utili e dipendenti dall’esperienza, con la necessità di adattare queste rappresentazioni al mondo che cambia.
Facciamo affidamento sulle nostre memorie a lungo termine per guidare i comportamenti futuri, rendendoli adattivi per dare priorità alla conservazione delle informazioni salienti e rilevanti.
Nonostante la nostra forte tendenza a considerare la memoria come una rappresentazione accurata di eventi passati, è stato dimostrato che i ricordi non sono entità fisse, bensì vengono condizionati dalla salienza emotiva del ricordo stesso.
In generale, gli eventi emotivamente carichi hanno maggiori probabilità di essere ricordati. Ma perché avviene ciò? Perché i nostri ricordi sono filtrati e distorti dai nostri interessi ed emozioni. Ad esempio, due persone che sostengono squadre di calcio o partiti politici avversari registreranno e ricorderanno cose molto diverse e probabilmente non saranno d’accordo sui “fatti”.
Questo avviene perché la memoria è, in generale, organizzata secondo principi affettivo-emozionali: ciò significa che le emozioni che proviamo mentre viviamo un dato evento determinano il modo in cui lo ricorderemo in futuro, ed è quindi possibile, per esempio, ricordare con ansia un ricordo apparentemente felice, perché ciò che conta non è la trama del ricordo bensì l’emozione che provavamo quando abbiamo vissuto quell’esperienza specifica.
Potremmo non ricordare più cosa è successo quel giorno o potremmo aver dimenticato molti dettagli dell’evento, ma il nostro corpo lo ricorda. Anche se inconsapevolmente, il corpo ricorda le sensazioni fisiologiche associate al momento dell’evento, come respiro affannoso, disagio, ansia, sudorazione, dolore, ecc., ed è proprio questo aspetto che mantiene viva, ad esempio, una fobia, anche se abbiamo già dimenticato l’evento traumatico a un livello più esplicito.
Come detto, quindi, i nostri ricordi e la nostra memoria sono fortemente influenzati dalle emozioni che proviamo, e questo fa sì che il ricordo di un evento sia “deformato” in modo molto soggettivo, creando la “nostra versione dei fatti” e il modo in cui il cervello, quando ricorda, ricostruisce una determinata esperienza.
Se dovessimo rivedere all’indietro la nostra vita, quali sono i ricordi che abbiamo più vividi? Sono ricordi emotivi o situazioni che non ci hanno fatto provare nulla? Come diceva lo scrittore Gabriel Garcia Marquez: “La vita non è quella che hai vissuto, ma quella che ricordi e come la ricordi per raccontarla”.
__